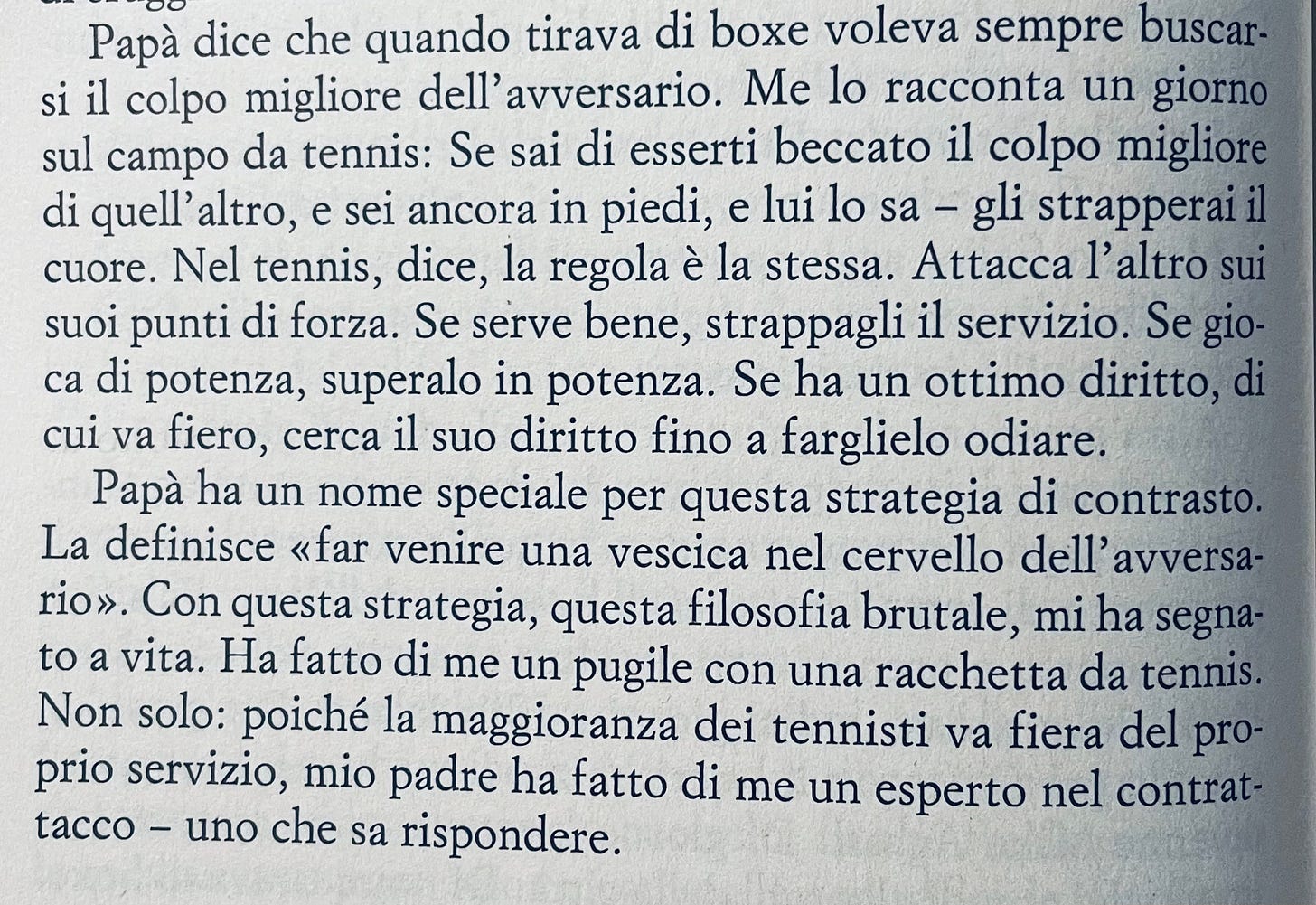Raccontare una cosa che ti fa male
Ordine cronologico, incipit, metafore e similitudini da usare in terapia
Da dove cominci a raccontare la storia del tuo dolore? Per quanto possa sembrare una domanda esistenziale è in realtà molto pratica, perché è né più né meno ciò che devi fare alla tua prima seduta di psicoterapia.
Almeno io, nonostante di quelle settimane ricordi davvero tutto in modo confuso, non riesco a dimenticarmi la sensazione subito dopo essermi seduto nel suo studio per la prima volta, aver appoggiato i palmi aperti delle mie mani sui braccioli della sua poltrona, averla guardata negli occhi mentre con un sorriso gentile cercava di leggermi, e averle poi sentito pronunciare un innocuo eppure sterminato "Mi racconti che succede."
Chissà che mi aspettavo. In quanti altri modi può cominciare un rapporto con la terapia? Una cosa così grande che inizia all'improvviso per forse non finire mai, è come pensare a un incipit.
Ricordo proprio la sensazione di non sapere da dove iniziare. "Non so neanche da dove iniziare" è una frase comune, che diciamo spesso, ma in quel preciso caso ne ho compreso il significato più urgente, perché ero nella situazione in cui dovevo per forza iniziare da qualche parte.
Il primo ordine che viene in mente è quello cronologico, sapete il "c'era una volta". Poi c'è anche l'ordine cronologico però a ritroso. Partire da oggi, poi ieri, e tornare indietro fino all'origine, seguendo sempre il tempo.
Io non penso di essere riuscito, in quel momento, né a focalizzare un criterio da seguire, né ad avere la lucidità di mettere in ordine i fatti, perché ben presto ho capito che ad avermi ridotto in quello stato non erano stati dei "fatti".
È un esercizio utile quello del raccontare una storia che ci fa male, perché se la racconti come si racconta di solito una novella, cioè seguendo il classico schema della narratologia, ti rendi conto che qualcosa non funziona: sembra una storia banale. Quasi non riconosci il male che ti fa.
Raccontarla significa tentare di capirla. Per questo in quella prima seduta, a quella domanda, ho risposto con una frase brevissima, il più semplice possibile, soggetto verbo e complemento, che riassumeva e al tempo stesso generava il mio dolore.
Per quanto sembri assurdo, la differenza tra la lingua pensata e il discorso è che una frase puoi anche pensarla per mesi, ma da concetto diventa "cosa" soltanto quando la pronunci davanti a qualcuno che ti ascolta; e quella frase che ho detto per me è stata come tossire, e vedere il dolore che mi stava bruciando dentro prendere forma sul tappeto come catarro. Aveva una forma, un colore, una delimitazione spaziale che potevo finalmente percepire.
Portato a galla il nucleo del malessere, sottoforma di una frase modulata dalla mia bocca e pronunciata, dovevo capire come continuare. Liberatomi del macigno, con quell'esordio che forse ha fatto in modo che la mia terapia prendesse da subito una strada costruttiva, ho sentito poi la responsabilità di farmi capire, di dare una bussola alla mia psicoterapeuta per rendere navigabile questa vicenda in cui io stesso mi ero perso. Ho pensato che la cosa più comprensibile di tutta la storia potessero essere le persone, perciò ho iniziato a delinearne i tratti, come si fa quando si introducono i personaggi in un libro. Mi rendevo conto di essere troppo spento e angosciato per poter dare una narrazione oggettiva nonostante mi sforzassi verso il verismo; ancora non capivo che soprattutto la lettura parziale che io davo della realtà attorno a me era la bussola per chi mi ascoltava, e non tanto la veridicità della storia.
Ed è andata così in questi due anni, più simile al disegnare una mappa che allo scrivere una storia. L'inizio tracciando i segni fondamentali del cuore della mappa, poi le coordinate per definirne la scala, poi tutti i vari quartieri, le strade, i ponti, come si collegano le cose distanti, e poi è lungo lavoro di dettaglio, minuzie che rivelano la profondità e le radici. Perché poi nel racconto scopri che non c'è un lieto fine o un finale amaro; è che proprio non c'è la fine. Tutte le storie ce l'hanno una conclusione, e cominci a dubitare che la psicoterapia riguardi il raccontare storie.
-Ho smontato il giocattolo per vedere come funzionava, poi l'ho rimontato e mi è avanzato un pezzo che non ricordo più dove andava.
-Ho la sensazione di esserci già stato qui, ma adesso mi sembra di vedere tutto da più lontano.
-È come quando riempi troppo un bicchiere e quindi lo porti pianissimo alla bocca per non spandere acqua.
-Mi viene in mente quando facciamo una capriola, e vogliamo che la mamma ci guardi per dirci "bravo".
-Ho fatto saltare il ponte.
Il difficile di raccontare una storia che ti fa male è anche che ha poco a che fare con le azioni. Sono perlopiù sensazioni incorporee, con collegamenti opachi, cose invisibili che sentiamo il bisogno di spiegare. Col tempo verrà quasi naturale esercitarsi in similitudini, che diventano metafore quando prendi un po' di confidenza con la terapeuta. È come se fosse tutto un lungo esercizio di portare a terra cose immateriali. Il dolore, la vergogna, l'angoscia, la tristezza, il senso di abbandono, la paura, il terrore di essere accantonati, tutto questo che si incarna in immagini, oggetti, macchine parcheggiate, bicchieri rotti, regali sbagliati, ordini al ristorante.
Prima o poi la mappa dell'incorporeo si cataloga in dei pattern ricorrenti delle tue azioni concrete, che possono effettivamente assomigliare a cose che metteresti in un libro o in un racconto, cose che fanno una storia.
Non è per questo motivo che vado in terapia, lo faccio per cambiare comportamenti e reazioni di cui sono prigioniero e che non mi piacciono, ma mi sono scoperto a ragionare sulle metafore che cominciavo a usare con sempre maggiore disinvoltura, accorgendomi che a lei il gioco piaceva, perché le riprendeva, le complicava, ci aggiungeva una prospettiva sua. Allora lì mi sono accorto che probabilmente ero riuscito a costruirla la mappa, e più ci capiva lei, più riuscivo a capirci io.
Non so se riuscirò mai a scrivere una storia come si deve, per far sì che guarisca sia me che chi la legge; quello che ho capito in questi anni, su quella poltrona, è che se la storia l'avessi raccontata da solo mi sarebbe uscita molto peggio.